
Sempre di più oggi ragioniamo “per generazioni” e soprattutto, quasi in ogni campo, mettiamo in evidenza le differenze che intercorrono tra l’una e l’altra e le rendono particolarmente caratterizzanti. I Boomers (ossia quelli nati tra il 1946 e il 1964) sono meno propensi alla tecnologia, preferiscono fare le telefonate, sono su Facebook e non su TikTok e tengono al posto fisso. I Millennials (nata tra il 1980 e 1996), invece, hanno una mentalità aperta, amano viaggiare, preferiscono cambiare azienda senza fossilizzarsi, usa come social Instagram e TikTok e così via.
Sono aspetti che riconoscete? Probabilmente sì e, se lavorate nel mondo HR, di tali differenze generazionali piuttosto standardizzate tenete probabilmente conto quando state iniziando una fase di recruitment, progettate l’onboarding, pensate a nuovi ruoli di cui l’azienda ha bisogno. Ma questa suddivisione tra le generazioni si cala davvero nella realtà che viviamo tutti ogni giorno? Se è vero che può servire quando si progettano le buyer personas (ossia acquirenti tipo) o si fa una campagna social ragionando per cluster, d’altro canto non siamo in fondo tutti umani e contrassegnati dagli stessi timori, le stesse paure, le stesse incertezze? E non abbiamo forse tutti lo stesso bisogno di sentirci gratificati in quello che facciamo, di appassionarci a qualcosa, amare ed essere amati?
E categorizzare il lavoro, così come le proposte formative in base alle differenze generazionali, non vuol dire in un certo senso perpetrare un bias? Ossia cavalcare un pregiudizio dimenticando la specificità di ogni persona?
È una riflessione che vogliamo fare in questo articolo guardando le generazioni e le generalizzazioni da un altro punto di vista.
Ageismo e bias: quando i pregiudizi sono “accettati”
Quando si parla di bias, ossia di pregiudizi, più o meno consapevoli, ce ne sono alcuni che emergono più di altri perché più noti o forse più facilmente riconoscibili. Confrontarsi, per esempio, con persone che la pensano come noi e tendere a evitare chi ci fa sentire a disagio ha a che fare con il bias di conferma. Un pregiudizio che spesso “subodoriamo” ma che continuiamo a perpetrare.
Il bias di conferma è poi molto legato al bias di gruppo: tendiamo a sopravvalutare le capacità e il valore del nostro team, pensando che i nostri siano successi meritati mentre guardiamo a quelli altrui come esperienze fortunate senza che ci sia un effettivo merito. Anche questa è una distorsione cognitiva che può portare non pochi fraintendimenti oltre che verso una totale incomunicabilità, specie all’interno della stessa azienda.
Un altro bias può essere il famoso effetto placebo: siamo convinti che quella cosa (medicina o altro) ci farà bene pertanto ce ne autoconvinciamo senza guardare oggettivamente quanto ci è utile.
Anche nell’ageismo rientrano i bias: con questa parola infatti si intende un costrutto sociale che ritrae gli anziani, ma anche i più giovani, in modo stereotipato cavalcando pensieri comuni senza verificare se di fatto sia così. Si tratta di stereotipi che, in qualche modo, sono socialmente “accettati” oltre che particolarmente diffusi. E questo è dovuto al fatto che l’aspetto anagrafico è qualcosa di molto oggettivo. Come dire: sull’età non si può mentire, quella è.
Senza dimenticare poi che, secondo gli esperti, esistono 3 tipi di ageismo:
- ageismo istituzionale che si verifica quando un’istituzione (sia essa la scuola o altro) lo porta avanti attraverso le sue azioni e politiche;
- ageismo interpersonale che si verifica nelle interazioni sociali;
- ageismo interiorizzato: quando una persona fa sue queste convinzioni e le applica a sé stessa.
Tutto ciò che viene quindi costruito attorno a un numero, qual è l’età, può determinare dei veri e propri problemi. Se è vero che essere anziani o giovani è qualcosa che non possiamo evitare – nonostante la medicina estetica e le varie creme e cremine – si può comunque ovviare cercando di non ragionare solo in base all’età. Dire vecchio o giovane potrebbe, come suggerisce Valentina Di Michele nel libro “Scrivi e lascia vivere” (Flacowski), essere sostituito da espressioni come “persone di fascia di età alta” e “persone di fascia di età bassa”.
Le parole sono importanti diceva – anzi urlava – Nanni Moretti nel film “Palombella Rossa” e per chi gestisce persone e vuole aumentarne il benessere, in azienda e non solo, sono un aspetto non indifferente. Ma non bastano le parole, è importante cercare di andare oltre la categorizzazione che sì, fa comodo, ma non fa altro che avallare certi modi di pensare dimenticando che dietro appunto ci sono le persone. Questo vale sia per il modo di gestire il lavoro che di portare avanti la formazione.
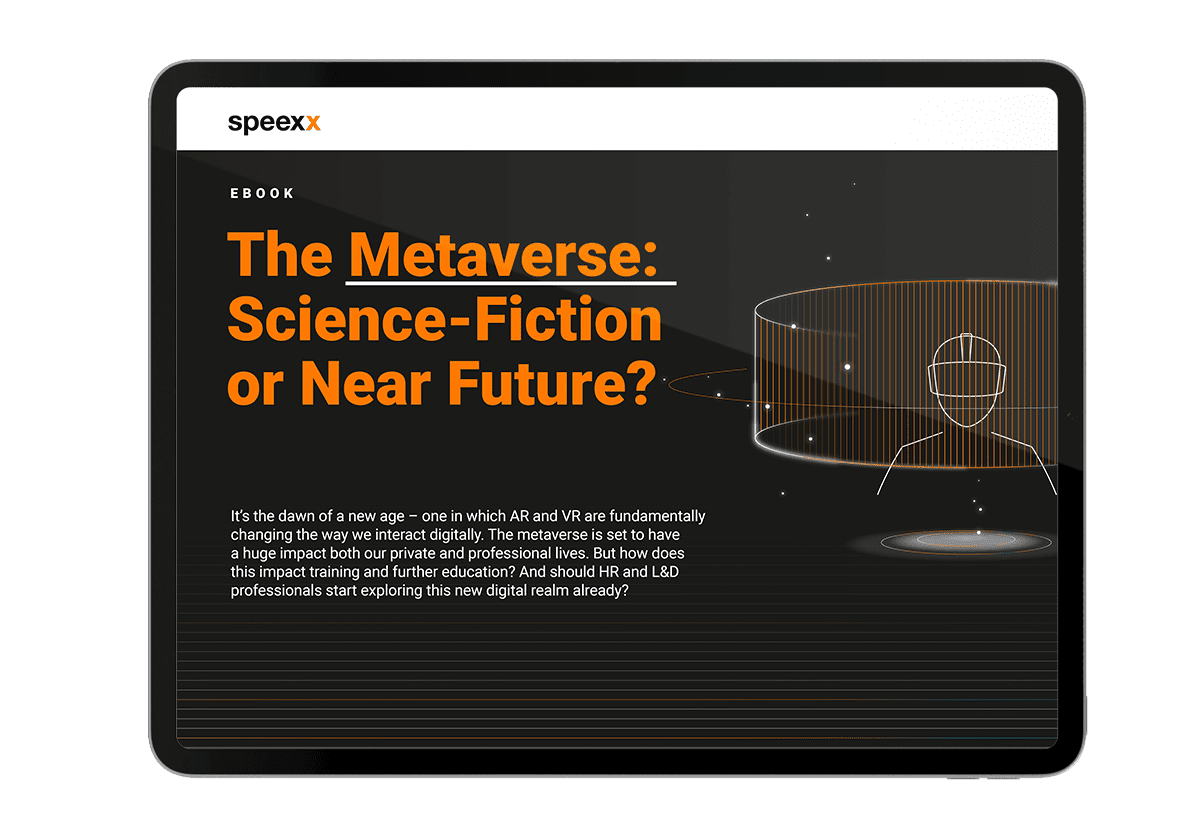
Diversificare lavoro e formazione in base all’età non vuol dire portare avanti un bias?
Il Global Report on Ageism, prodotto dall’OMS, peraltro ha evidenziato come 1 persona su 2 – su 83000 intervistati proveniente da 57 Paesi – abbia moderati o elevati atteggiamenti discriminatori legati all’età, il che si ripercuote sull’attrattività dei talenti ma anche sulla retention, ossia il trattenere chi è davvero valido.
Lo studio dal titolo Ageism at Work ha poi evidenziato che per la maggioranza degli intervistati il mercato del lavoro è chiuso dopo i 55 anni, il 33% ha perso interesse per il proprio lavoro a causa della mancanza di opportunità di carriera e il 24% si sente costretto a pensare alla pensione ancor prima di quanto ne sente la necessità.
Alla luce di questo è importante agire per non rafforzare queste sensazioni, ma piuttosto accoglierle e “sviscerarle”.
Cosa significa? L’ideale sarebbe conoscere davvero a fondo la propria popolazione aziendale, magari con questionari e workshop che tra le altre cose possano evidenziare situazioni in cui l’età diventa un peso.
In secondo luogo bisogna lavorare per creare una cultura positiva relativa all’età, in cui tutti i dipendenti possano partecipare a pieno all’attività dell’azienda.
Nel concreto, si potrebbe:
- evitare politiche pensionistiche che si rivolgano a categorie di lavoratori omogenei. Capire se tra queste ci sono attività fisicamente impegnative così come tra chi è vicino alla pensione, se c’è qualcuno che vuole ancora continuare a lavorare. Una persona cui magari proporre un ruolo di consulente o di supporto, per esempio.
- Incoraggiare i manager a valutare le skill e il modo in cui queste, comprese le soft skill, corrispondano al ruolo che si ricopre e non in base all’età. Questo vale sia per le persone di fascia d’età alta con una certa esperienza che per quelli più giovani che a volte non vengono considerati proprio per il motivo opposto, ossia perché “non sono abbastanza per…”.
- Creare gruppi/reti di risorse per i dipendenti per coinvolgere persone di generazioni diverse e fornire loro una piattaforma per discutere apertamente delle loro preoccupazioni. Possono essere le community oppure com’è successo in alcune aziende sostenere i cosiddetti ERG, ossia gli Employer Resource Group che sono gruppi spontanei di dipendenti.
- Garantire che tutte le riunioni e le attività sociali aziendali siano pienamente inclusive e incoraggiare tutti a partecipare.
- Promuovere i modelli di comportamento giusti e far notare quelli sbagliati: è importante incoraggiare la responsabilità individuale e dare spazio alle parole giuste o sbagliate in un luogo di lavoro. In proposito vi consigliamo di seguire un TED dal titolo “Come ridurre i bias sul luogo di lavoro” (lo trovate a metà articolo).

Progettare corsi di formazione al di là dell’età
Tutto questo vale anche per la progettazione di corsi di formazione. A volte, per quelli interni, si tende a suddividere i gruppi di partecipanti per età. Il corso è lo stesso, ma si pensa, specie quando si ha a che fare con il digitale, che abbia più senso pensare a una modalità più avanzata per chi è più giovane e a un corso più basico per chi ha un’età più alta. Questo può essere molto pericoloso per vari motivi.
Innanzitutto si porta avanti il bias legato all’età e si avallano fenomeni di ageismo in azienda, ma non solo: non si sta veramente partendo da quello che è il livello di conoscenza delle persone a prescindere dalla loro anagrafica.
L’ideale sarebbe non dare tutto per scontato, ma possibilmente verificare quanto una persona sa di quell’argomento sia per lavoro che per diletto. Magari un dipendente può non gestire social media, blog aziendali e altri canali digital, ma avere un suo progetto personale e saperne molto. E questo pure se ha superato da un bel pezzo i 50 anni. Così come ci potrebbe essere qualcuno che appartiene alla Generazione Z (un neolaureato per esempio) ed essere totalmente disinteressato ai social.
Altro aspetto da non trascurare è che progettare corsi di formazione con la partecipazione di persone di generazioni diverse è una grande ricchezza. Durante i corsi, specie se avvengono dal vivo, si lavora in gruppi, ci si conosce più a fondo, si ha modo di scambiare quattro chiacchiere e confrontarsi sia sul lavoro che su aspetti che c’entrano poco. Si favorisce quello scambio intergenerazionale ma anche legato a funzioni di business diverse che rende un’azienda ancora più ricca.