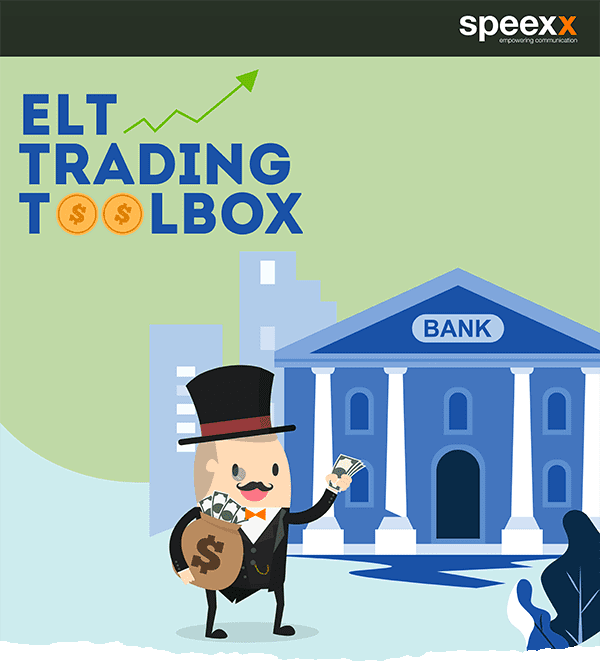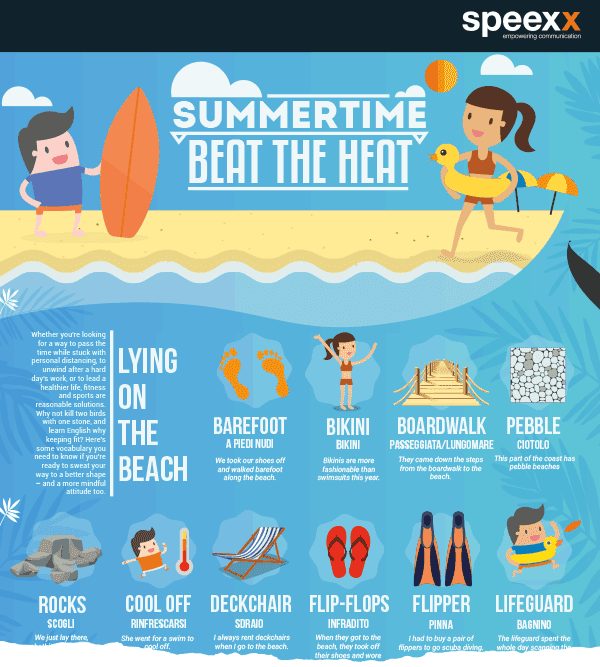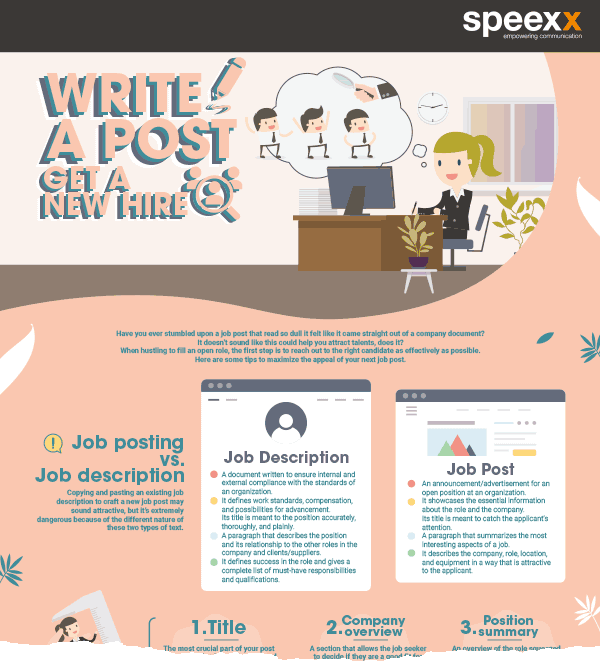Intervista a Giulia Moretto | Vivere il cambiamento: un ponte tra culture e tra chi siamo e chi vorremmo essere
Affrontare un cambiamento può essere difficile. Servono: una buona dose di fiducia in sé stessi, di adattabilità e di apertura mentale a nuovi modi di vedere le cose. Questo vale nella vita privata tanto quanto nella vita professionale. Anzi: “Non è possibile fare un importante cambiamento di carriera se non si agisce anche sulla dimensione personale, è come fare un lavoro a metà”. Ad affermarlo è Giulia Moretto, consulente in Personal & Career Change Management e Consapevolezza Interculturale.
Cambiare, ci ha spiegato, significa costruire ponti tra chi siamo e chi vorremmo e potremmo essere. Questi ponti hanno anche a che fare con la seconda parte del suo job title, con la consapevolezza interculturale, per cui incontriamo ogni giorno, anche sul luogo di lavoro, persone di culture altre con cui comunicare. Moretto, infatti, seguendo le persone nel loro cambiamento di carriera, si è accorta di quanto fosse sempre più importante accompagnarle anche in uno culturale, dato che provengono da ogni parte del mondo.
Quali sono i motivi che spingono una persona a cambiare vita e lavoro?
Sono vari. C’è il desiderio di cambiare perché si vuole dare un nuovo senso, un nuovo scopo. Poi la curiosità di esplorare. Molte persone sono curiose di vivere nuove situazioni e nuovi stimoli. Spesso questo nasce da una sfida con sé stessi, per testare le proprie capacità: sarò in grado di affrontare il nuovo? Ce la farò? Ma c’è anche un terzo motivo: la fuga. Si vuole scappare da una situazione che ci sta scomoda. Infine, si cambia anche per il presentarsi di nuove opportunità anche se non lo avevamo previsto.

Come si gestisce un cambiamento e quali sono le risorse che una persona deve mettere in campo per riuscirci?
Alla base di un cambiamento devono esserci due cose fondamentali che si contrastano: il pragmatismo e un po’ di pazzia. Il primo aspetto è legato all’organizzazione, il secondo a quella capacità di fare un salto nel vuoto, di provare qualcosa di inedito. Poi ci sono molte altre risorse: il coraggio, la consapevolezza della fatica, la curiosità, saper accettare anche le situazioni negative. Di sicuro occorre una buona dose di fiducia in sé stessi e infine grande resilienza e adattamento per fronteggiare anche l’imprevedibile. C’è tanto da gestire, per questo spesso bisogna anche farsi aiutare.
Quali sono le ragioni che spesso spingono le persone a resistere al cambiamento?
La resistenza al cambiamento di solito è dovuta al fatto che si entra in contatto con una diversità. Di ambiente, di mentalità, di cultura. E questa diversità fa paura, perché mette in dubbio chi siamo. È naturale che ci spaventa lasciare il conosciuto, che ci dà sicurezza e stabilità, per lo sconosciuto. Si pensa che per cambiare occorra abbandonare noi stessi, tutto quello che siamo e a cui apparteniamo. Invece io dico sempre che non è un abbandono ma un’integrazione: lasciamo andare quello vediamo come una zavorra e che ci ha spinto a cambiare e teniamo la nostra ricchezza. Un altro tipo di resistenza poi è legata all’aspetto interculturale, alla convinzione di essere il massimo e il meglio che ci sia. Questo è il limite più grande a qualsiasi cambiamento perché non c’è neanche lo stimolo a vedere nuove vie.
Che cos’è il cambiamento in ottica DEI?
DEI è la sigla per Diversity Equality Inclusion. La chiave nella DEI è l’apertura verso sé stessi e verso l’altro. Noi stessi dobbiamo innanzitutto capire da dove veniamo e dove siamo, e poi capire da dove arriva l’altro e dov’è, per capire il luogo comune in cui incontrarsi e accogliersi. Si guarda più spesso all’unicità dell’altro per integrarla con la nostra ma dovremmo capire prima le nostre di unicità per dialogare con quelle degli altri. Le persone sono più propense a dire “accetto l’altro”, piuttosto che pensare di farsi accettare. Qui c’è anche un nuovo senso di fiducia in sé stessi che esula dall’egocentrismo, perché si lega alla messa in discussione come spazio di vulnerabilità.

Che cos’è la consapevolezza interculturale?
Quello di cui io mi occupo, sebbene cultura abbia a che fare con senso di appartenenza a un gruppo non per forza legato a un paese, è interculturalità dal punto di vista di dialogo tra le culture dei paesi. La consapevolezza interculturale è la capacità di comprendere la propria cultura, quella da cui proveniamo e che spesso diamo per scontata perché ci nasciamo dentro, e la volontà di comprendere la cultura dell’altro per riuscire a relazionarci meglio. Senza offenderci o ferirci. Perché sappiamo che gli aspetti culturali spesso feriscono, perché non sono tra loro uguali e danno forma al nostro modo di comportarci.
Quali benefici porta, anche a livello aziendale, cambiare in questo senso?
Il beneficio immediato è il miglioramento della relazione tra due entità che appartengono a due culture. Dopo ce ne sono ulteriori che possono avvenire in vari contesti, perché la consapevolezza culturale non ha solo un impatto sulla persona ma ce l’ha anche a livello aziendale. La DEI contribuisce a migliorare la comunicazione all’interno di un gruppo di lavoro, e quindi fa aumentare la fiducia tra i collaboratori, il benessere e il senso di appartenenza a un ambiente. Il gruppo lavora meglio, con diverse visioni e varie soluzioni, portando innovazione nell’azienda. Migliorando la comunicazione, diminuiscono le incomprensioni e si ottimizzano i risultati. Quello che le aziende dovrebbero considerare inoltre è che il vero cambiamento deve arrivare ai piani alti. Si pensa che l’inclusione si debba creare partendo dal basso, invece è il contrario. I piani alti sono rappresentativi per chi arriva in azienda, se la diversità è lì ci saranno più possibilità di identificazione e inoltre l’unicità delle visioni agirà nel prendere le decisioni.