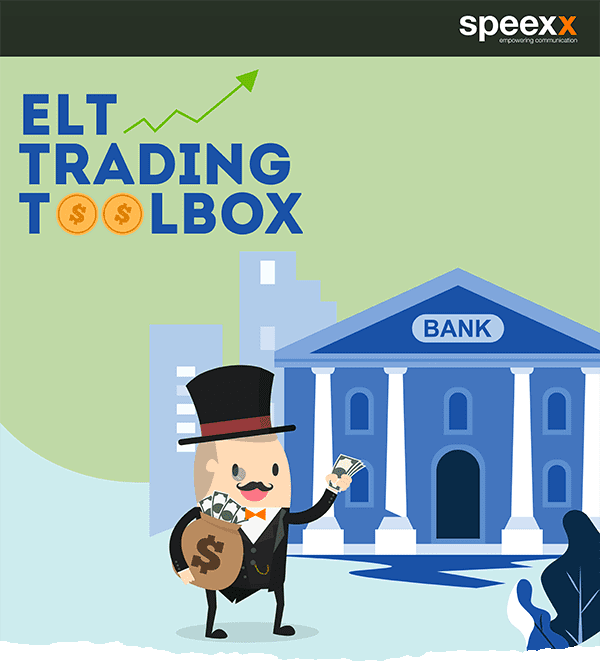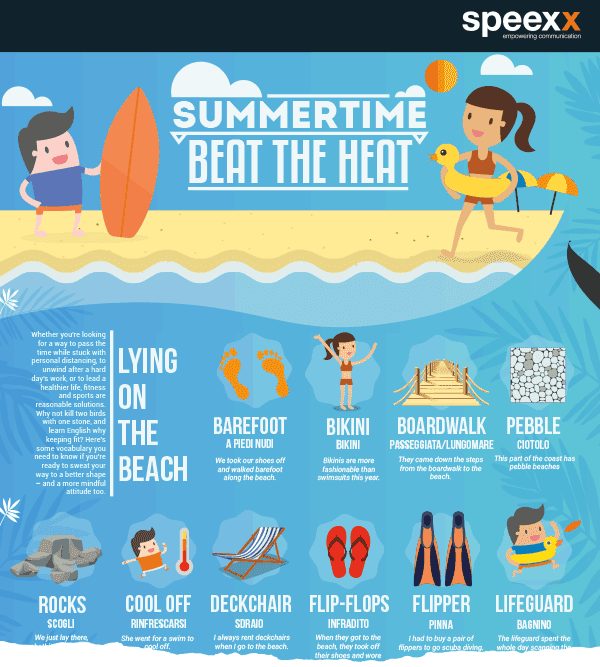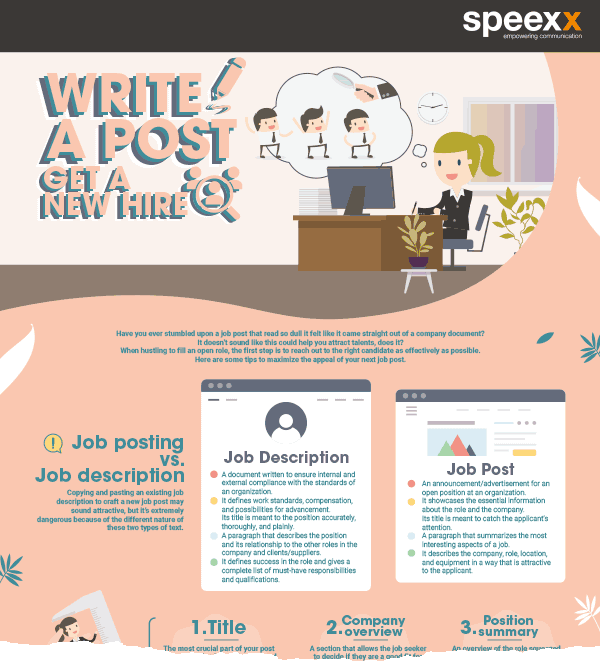Intervista a Fabrizio Acanfora | Neurodiversità e neurodivergenza: buone pratiche di inclusione in azienda
Avete mai fatto caso al fatto che, se usiamo la parola inglese, diversity, ci sentiamo più a nostro agio con la diversità? Quasi che, allontanandoci dall’italiano, anche il nostro cervello si allontanasse e riuscisse a vedere gli aspetti positivi che nascono dall’incontro con chi è diverso o diversa da me. Negli ultimi anni la diversity in azienda è diventata un valore, eppure la diversità è qualcosa che continuiamo a guardare con sospetto. Perché? Perché partiamo dal presupposto che la normalità, cioè quello che è adesso e tutti i giorni ed è sempre stato così, sia la base: e poi ci sono alcune persone diverse. L’unico modo per realizzare davvero la diversity, e tutti i benefici che sappiamo porta con sé, è iniziare allora a scegliere di vedere il mondo come un insieme di diversità. Ciascuna con il suo valore e la sua storia.
Questo è uno dei consigli che ci ha dato Fabrizio Acanfora, persona autistica, Neurodivergent Advocate, divulgatore scientifico, scrittore e conferenziere, docente universitario, pianista e clavicembalista, ex costruttore di clavicembali senza rimpianti, nel corso di una chiacchierata sul tema diversità e disabilità in azienda. Oltre a questo, abbiamo parlato anche di quali sono gli ostacoli all’occupabilità delle persone disabili e neurodivergenti, cioè persone autistiche, dislessiche e così via, se le categorie protette servono e come realizzare davvero una diversity in azienda che tenga conto e valorizzi la diversità.
Nella tua esperienza, quali ostacoli ci sono all’occupabilità e occupazione delle persone con disabilità e con neurodivergenze?
La disabilità, la neurodivergenza, la diversità in generale, non è ancora ben vista, nella società e in azienda. È ancora molto diffuso il pensiero, che proviene dal modello medico, classico e riparativo, per cui la persona disabile e neurodivergente non è che un cumulo di deficit da riportare a una condizione di normalità. È un approccio che, se nel suo ambito di origine, cioè quello medico, ha la sua funzione, porta però a presupporre che la disabilità sia un attributo della persona. Invece, se seguiamo il modello sociale, vedremo la disabilità come il risultato della lontananza tra una persona con le sue caratteristiche e una società che non è costruita per chi ha quelle caratteristiche. Scegliere di vederla in questo modo, solleva il pesante stigma che oggi ancora c’è sulle persone disabili e neurodivergenti.
Uno stigma che è il primo ostacolo all’occupabilità delle persone disabili e neurodivergenti. Finchè, tra l’altro, continuiamo a pensare all’inclusione come valore massimo da portare nelle nostre aziende, mettiamo in atto un processo verticale in cui una maggioranza formata da persone con caratteristiche consuete, cioè più simili a quelle per cui la società è costruita, decide a priori per chi invece è fuori da quella maggioranza. Le minoranze, così, restano escluse. È molto difficile pensare all’inclusività se non c’è autorappresentanza. E questo è il secondo ostacolo: quante volte, quando scriviamo le policy aziendali per le persone disabili, al tavolo con noi ci sono effettivamente persone disabili o neurodivergenti?
Per questo non mi piace parlare tanto di inclusione, quanto di comprensione delle differenze. Più che inclusiva, io parlerei di società accessibile. Già sarebbe un gran passo non vedere le persone diverse dalla maggioranza come sbagliate.
Altri ostacoli più generali all’occupabilità, o alla serenità sul posto di lavoro della persona disabile o neurodivergente, possono essere la mancanza di sensibilità sul tema, una cultura aziendale non comprensiva delle differenze e mancanze di budget per venire incontro alle esigenze delle persone. In tale situazione, il rischio per le persone disabili è anche quello di esporsi perché dall’altra parte molte volte non c’è conoscenza e c’è pregiudizio. Quante volte ci capita di non essere presi sul serio! Per non parlare poi di chi, agli occhi della maggioranza, sembra poco disabile e allora sa che le sue esigenze non verranno mai ascoltate. O, qualora lo fossero, poi sarà necessario far capire ai colleghi che tali richieste non sono l’espressione di un privilegio, ma il raggiungere una condizione che consente alla persona di fare il suo lavoro bene, tanto quanto i colleghi e le colleghe.

–
Quali sono gli accorgimenti e le best practice che un’azienda oggi potrebbe decidere di inserire per rendere il proprio processo di recruiting più accessibile?
Il processo di recruiting già è stressante per chiunque, immaginate cosa potrebbe essere se è pensato solo per chi ha le caratteristiche della maggioranza. Faccio qualche esempio: il sito web della vostra organizzazione è accessibile? Le vostre job offer su LinkedIn sono scritte in modo accessibile o sono muri di testo senza formattazione e con richieste poco chiare? Già da questi primi due touchpoint si sta operando una scrematura discriminatoria molto forte: e state tagliando fuori una grande fetta di talenti.
Il colloquio di lavoro, sia in presenza sia da remoto, è un’altra situazione che potrebbe diventare molto discriminatoria all’accesso per le persone disabili e neurodivergenti. Se l’azienda ha barriere architettoniche, per esempio, oppure se lo spazio non tiene conto della ipersensibilità a luci e suoni, che potrebbe mettere in difficoltà molte persone neurodivergenti; per non parlare della socialità, ora con il Covid non accade più spesso, ma per chi ha una socialità diversa, anche darsi la mano diventa un’importante fonte di stress che mi svantaggia rispetto a una persona neurotipica. Il colloquio stesso viene condotto e valutato secondo criteri neurotipici, per esempio, il fatto di non guardare chi ho di fronte negli occhi, per me è un modo di concentrarmi, ma per il o la HR potrebbe essere motivo di disagio.
A questo punto, se va tutto bene, sono assunto. E l’azienda non è pronta. I colleghi non sono pronti né lo è lo spazio fisico. La best practice è quella di prepararsi in anticipo all’arrivo di persone che hanno funzionamenti differenti.
E per quanto riguarda il post assunzione, quali sono gli accorgimenti da inserire nelle policy, di comunicazione, di cultura aziendale per favorire il benessere delle persone disabili e neurodivergenti?
È bene ricordare che la diversità non deve essere vista come un problema da superare, ma un valore, un vantaggio da cogliere. Vi porto un esempio personale, quando ho iniziato il mio ultimo lavoro ho fatto alcune richieste di piccoli cambiamenti che però per me sono fondamentali per lavorare bene: ho chiesto di preferire le email, scritte in modo chiaro, evitando riunioni in presenza e rispettare i turni di parola nei meeting. All’inizio sembrava strano, ma poi ha avvantaggiato tutti.
Spesso aziende poco accessibili sono il frutto di persone che non sanno come relazionarsi con la diversità. La formazione, dunque, è fondamentale. Ho parlato con un Diversity Manager di una grande azienda dell’automotive. La sua preoccupazione era: se prendo una persona autistica e la tolgo dall’open space, poi come gestisco le richieste degli altri? Il secondo passo è quindi quello di creare una cultura che non vede queste decisioni come privilegi, ma come accorgimenti per consentire a tutti e tutte di avere le stesse possibilità di dare il proprio contributo. Il terzo aspetto è quindi quello di coinvolgere le persone come parte del processo, non come chi riceve delle concessioni o privilegi, ma come chi è parte dei processi decisionali e porta accorgimenti per migliorare la propria partecipazione.
Diversity quotas e categorie protette: servono?
Le categorie protette, così come le diversity quotas, sono mezzi che ritengo utili, ma non risolutivi. Credo che i cambiamenti divengano efficaci quando le cose vengono mosse da entrambe le direzioni, dall’alto e dal basso. Già solo esercitare l’ascolto a tutti i livelli, può aiutare molto di più. L’auspicio è che si arrivi a comprendere che non bisogna pensare a determinate categorie per portare miglioramenti a tutti i livelli. Si ascoltano le esigenze e si accompagnano i talenti, quelli di tutte le persone, alla loro fioritura.
Quanto è importante il linguaggio anche in questo ambito?
Da qualche anno va di moda nelle aziende parlare dei “super disabili” o “super autistici”, per indicare quei tratti delle persone autistiche che in un’azienda vengono viste come una sorta di superpotere: il genio autistico dell’informatica o il disabile che “se ce l’ha fatta lui, allora io. Provate a cercare “your excuse in invalid” su Google: si chiama inspirational porn e rende accettabile la disabilità solo quando è un vantaggio per chi non è disabile. Oppure pensate a quelle serie TV come The Good Doctor o Big Bag Theory, in cui i personaggi autistici sono fighi. Questo autismo è accettato socialmente, ma descrive una piccolissima percentuale. Se l’autistico non è un genio, che fa? Quando questa narrazione passa in azienda, avviene una discriminazione.
Perché tutto questo è importante? Perché il linguaggio favorisce il cambiamento culturale. Di solito, le parole utilizzate per definire e raccontare la disabilità provengono dal campo del dolore: le persone sono “affette” da autismo, “soffrono” di autismo, come se la nostra vita fosse sofferenze dalla mattina alla sera e così non è. Quel che accade è che ti rivedi in quel linguaggio, ma non ti ci rispecchi. E questo dà al resto della popolazione un’idea sbagliata, perché non è il modo in cui le persone disabili e neurodivergenti si definiscono.
Questo è l’altro tema importante. Quando una persona con neurodivergenze o disabilità cresce e non trova modelli in cui identificarsi positivamente, perché le sue caratteristiche non sono visibili o visibili in modo negativo, cresce o pensando di non esistere o cercando di normalizzarsi andando contro le sue caratteristiche, oppure nascondendosi pensando di essere sbagliato o sbagliata. Ecco perché prestare attenzione alle parole che usano le minoranze stesse per raccontarsi, e rispettare la decisione, è importante. Perchè stiamo dicendo loro: sì, ti vedo, esisti.
Quale linguaggio è meglio utilizzare?
Quando generalizzi fai sempre torto a qualcuno, chiedere a una persona come preferisce essere chiamata è sempre meglio. Nel dubbio, domandi. Sono stati fatti anche diversi sondaggi e risulta che le persone autistiche, una grandissima maggioranza, preferiscono il linguaggio identity first, “autistico”, perché riconoscono questa condizione come parte di loro stessi e stesse, come il proprio funzionamento. Per quanto riguarda le persone disabili, c’è invece una parte che preferisce l’approccio person first, “persona con disabilità”, suggerito anche a livello istituzionale. Ma è una cosa che va sempre scelta ed è fondamentale che, anche in azienda, le persone di cui si sta parlando, le persone neurodivergenti e disabili, siano sempre coinvolte in prima persona in ciò che le riguarda. Domanda, ascolto e coinvolgimento, sono queste le tre parole chiave.